|
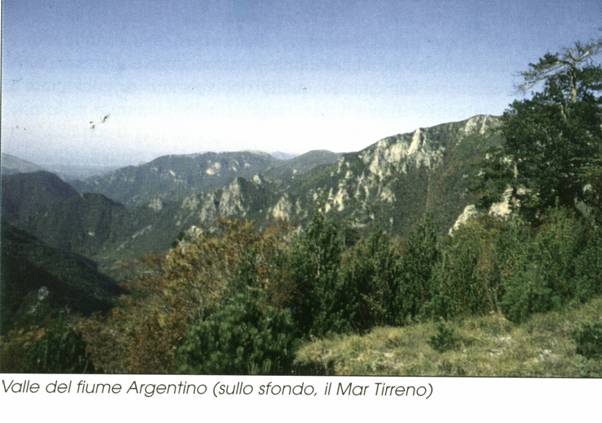 LA
PROVINCIA DI COSENZA LA
PROVINCIA DI COSENZA
La provincia di
Cosenza si estende su una superficie complessiva di 6.649,73 Km2 nella
zona settentrionale della Calabria. Il territorio è in buona parte
montuoso, con massicci e gruppi isolati, separati da valloni o da selle.
Al confine con la Basilicata si eleva il massiccio del Pollino che culmina
a 2.267 m. nella Serra Dolcedorme e che ospita una notevole diversità di
ambienti naturali così da risultare uno dei complessi montuosi più
significativi del nostro paese dal punto di vista naturalistico e
paesaggistico. Il massiccio è costituito da rocce calcaree, mentre le
colline e le basse vallate sono formate da marne, sabbie e conglomerati. A
sud, lungo il versante tirrenico, si ergono i Monti di Orsomarso (o
massiccio del Pellegrino), simili al Pollino, mentre la Catena Costiera,
composta prevalentemente di rocce metamorfiche, si allunga verso sud tra
la costa e la valle del Crati, fino a raggiungere il basso corso del
Savuto. La Valle del Crati, che separa nettamente la Catena Costiera
dall’altipiano della Sila, è una profonda fossa, longitudinale al
sistema appenninico, che il fiume Crati percorre a valle di Cosenza, prima
di attraversare l’estesa piana di Sibari che si apre tra il Pollino e la
Sila. L’ altopiano silano è una vasta regione, rivestita da fitti
boschi di pino laricio e faggio, con un’altitudine media compresa tra i
1.200 e i 1.400 m. Presenta pendii scoscesi ai margini e una superficie
dolcemente ondulata, attraversata da dorsali e groppe arrotondate. Le
formazioni rocciose dominanti sono i graniti. A sud la provincia di
Cosenza confina con quelle di Crotone e di Catanzaro. Nelle fasce costiere
il clima è tipicamente mediterraneo, con inverni miti e piovosi ed estati
calde e asciutte; procedendo verso l’interno si accentuano
progressivamente i caratteri del clima continentale, in particolare sui
rilievi più elevati dove, comunque, a inverni freddi si alternano estati
piuttosto fresche. Le precipitazioni sono abbondanti nelle aree più
elevate, specialmente in quelle del versante tirrenico, ma si riducono
sensibilmente fino a valori modesti nelle pianure e nelle zone ioniche. È
proprio nel paesaggio calabrese, così vario e articolato, che è
possibile, negli spazi ampi al di sopra delle rocce più alte, cogliere il
volo lento e potente dei grandi rapaci o quello battente dei falchi. Il
calmo volteggio, che improvvisamente può trasformarsi in una picchiata
vertiginosa, ci segnala la presenza di questi padroni dell’aria, da
sempre temuti e ammirati.
Sono i predatori, i cosiddetti “nocivi” perseguitati dai contadini e
dai pastori, gli stranieri che vengono da lontano, come il Falco
pecchiaiolo, localmente chiamato Adorno, che attraversa a maggio,
bersagliato dalle fucilate, lo stretto di Messina. Detestati o ricercati,
fatti oggetto di protezione o di persecuzione sistematica, investiti da
atavici pregiudizi, simbolo di regalità o portatori di malaugurio, i
rapaci si collocano, nel mondo animale, al vertice della catena
alimentare. E risentono degli interventi che l’uomo attua nell’
ambiente alterando equilibri che la natura ha provveduto ad instaurare con
tempi lunghi e lenti. La presenza dei rapaci su un territorio e il loro
stato di salute sono indicatori biologici importanti del grado di
alterazione dell’ambiente in cui vivono. Pur se tutelati dalla legge, i
rapaci sono tra le specie che oggi meritano maggior cura e protezione, se
non si vuoi correre il rischio che alcuni di essi scompaiano per sempre
dai nostri cieli. Perseguitati dai bracconieri, sovente vittime di esche
avvelenate, sono spesso in regresso, soprattutto laddove si verificano
pesanti e negative modificazioni ambientali. La diminuzione delle loro
prede naturali o il prelievo dal nido dei pulii per collezionismo o per
commercio, sono motivo dell’impoverimento numerico di questi uccelli. Ma
non meno dannose sono altre cause indirette. Le strade innanzi tutto,
quelle che squarciano boschi, tagliano pendici e prati, sventrano strati
di roccia, predisponendo il territorio a erosioni e frane inevitabili ed
aprendo zone, prima tranquille, al disturbo, alla caccia, agli incendi. Le
costruzioni: e cioè quell’edilizia selvaggia ed incontrollata che nella
nostra regione ha devastato in modo irreversibile le coste e che avanza
ineluttabile verso la montagna, prendendo il posto degli alberi,
stravolgendo panorami intatti e portand o
con sé traffico, inquinamento, rumore, fili elettrici, recinzioni,
acquedotti, gasdotti. E poi gli impianti per lo sci, le funivie, le
scalate, i deltaplani, i parapendii, le cave e le miniere, gli impianti
idroelettrici, le dighe. E quel che non fanno i disboscamenti e la
distruzione del sottobosco, lo causano gli incendi, in grado di devastare
habitat che avranno bisogno di tempi lunghissimi per ricostituirsi,
costringendo innumerevoli specie di animali a cercare altrove il cibo e i
siti di nidificazione. C’è poi il grande capitolo degli inquinamenti:
dell’aria, dell’acqua, del suolo. Lungo un percorso che parte dai
piccoli insetti avvelenati con la chimica agricola, la morte avanza e si
concentra nei predatori che sono in vetta alla piramide alimentare. Ma ci
sono anche veleni più mirati per i rapaci da annientare: il famoso
“boccone” che, insieme a trappole, lacci e tagliole fa parte
dell’arsenale di caccia di chi continua a considerare “nocivi” i
rapaci. Alla caccia è da addebìtare, purtroppo, la causa principale
della morte o del ferimento dei rapaci. È veramente drammatica la portata
di quel fenomeno che va sotto il nome di bracconaggio. Incuranti delle
leggi che considerano questi volatili specie particolarmente protette, i
bracconieri mettono in atto una vera e propria carneficina che si perpetua
nel corso dell’intero anno, con un indice di punibilità prossimo allo
zero, vista l’inadeguatezza numerica degli addetti al controllo in
rapporto alla vastità e all’impervietà delle aree da controllare e ad
un numero di bracconieri che non accenna a diminuire. Secondo una ricerca
condotta da Birdlife International e dalla LIPU, il 43% di tutte le specie
di uccelli europei è in declino. Alcuni rapaci rischiano davvero di non
esserci più nel giro di pochi anni. È il caso, in Italia, del
Capovaccaio, relegato ormai in alcuni siti della Calabria e della Sicilia,
ridotto a poche coppie nidificanti; o dell’Aquila del Bonelli o del Gufo
reale nel Centro-sud. Finalmente dal 1991 l’Italia si è dotata di una
legge-quadro, la n. 394, sulle Aree Naturali Protette. È dunque possibile
impostare in modo organico una valida politica della conservazione della
natura e dei parchi naturali, intendendo la conservazione come uno
strumento fondamentale di pianificazione e di gestione, un diverso modello
di governo del territorio, compatibile con l’ambiente naturale. Ciò al
fine di promuovere uno sviluppo economico e sociale rispettoso della
conservazione e della tutela delle risorse naturali, ma allo stesso tempo
capace di favorire l’affermazione di nuove professionalità nel campo
dei beni culturali e ambientali e delle attività turistiche
eco-compatibili. È indispensabile che l’istituzione di parchi, riserve,
aree protette avvenga secondo un piano integrato che assicuri la continuità
e la diversità biologica. Vanno promossi piani d’azione per
reintrodurre e conservare specie in via di estinzione, bisogna dedicare
molte energie alle iniziative’di sensibilizzazione della gente,
all’educazione ambientale nelle scuole, all’informazione che veicoli
conoscenza e amore per la natura. È proprio in quest’ottica che abbiamo
lavorato a questa pubblicazione che tratta essenzialmente gli uccelli
rapaci della Calabria, con particolare riferimento alla provincia di
Cosenza. Un rilievo 1specifico è riservato al C.R.A.S. (Centro
di Recupero Animali Selvatici) di Cosenza, che ormai da un decennio svolge
il compito primario di provvedere al recupero e alla riabilitazione dei
tanti selvatici feriti, con l’obiettivo di riportarli, liberi, nel loro
ambiente naturale. o
con sé traffico, inquinamento, rumore, fili elettrici, recinzioni,
acquedotti, gasdotti. E poi gli impianti per lo sci, le funivie, le
scalate, i deltaplani, i parapendii, le cave e le miniere, gli impianti
idroelettrici, le dighe. E quel che non fanno i disboscamenti e la
distruzione del sottobosco, lo causano gli incendi, in grado di devastare
habitat che avranno bisogno di tempi lunghissimi per ricostituirsi,
costringendo innumerevoli specie di animali a cercare altrove il cibo e i
siti di nidificazione. C’è poi il grande capitolo degli inquinamenti:
dell’aria, dell’acqua, del suolo. Lungo un percorso che parte dai
piccoli insetti avvelenati con la chimica agricola, la morte avanza e si
concentra nei predatori che sono in vetta alla piramide alimentare. Ma ci
sono anche veleni più mirati per i rapaci da annientare: il famoso
“boccone” che, insieme a trappole, lacci e tagliole fa parte
dell’arsenale di caccia di chi continua a considerare “nocivi” i
rapaci. Alla caccia è da addebìtare, purtroppo, la causa principale
della morte o del ferimento dei rapaci. È veramente drammatica la portata
di quel fenomeno che va sotto il nome di bracconaggio. Incuranti delle
leggi che considerano questi volatili specie particolarmente protette, i
bracconieri mettono in atto una vera e propria carneficina che si perpetua
nel corso dell’intero anno, con un indice di punibilità prossimo allo
zero, vista l’inadeguatezza numerica degli addetti al controllo in
rapporto alla vastità e all’impervietà delle aree da controllare e ad
un numero di bracconieri che non accenna a diminuire. Secondo una ricerca
condotta da Birdlife International e dalla LIPU, il 43% di tutte le specie
di uccelli europei è in declino. Alcuni rapaci rischiano davvero di non
esserci più nel giro di pochi anni. È il caso, in Italia, del
Capovaccaio, relegato ormai in alcuni siti della Calabria e della Sicilia,
ridotto a poche coppie nidificanti; o dell’Aquila del Bonelli o del Gufo
reale nel Centro-sud. Finalmente dal 1991 l’Italia si è dotata di una
legge-quadro, la n. 394, sulle Aree Naturali Protette. È dunque possibile
impostare in modo organico una valida politica della conservazione della
natura e dei parchi naturali, intendendo la conservazione come uno
strumento fondamentale di pianificazione e di gestione, un diverso modello
di governo del territorio, compatibile con l’ambiente naturale. Ciò al
fine di promuovere uno sviluppo economico e sociale rispettoso della
conservazione e della tutela delle risorse naturali, ma allo stesso tempo
capace di favorire l’affermazione di nuove professionalità nel campo
dei beni culturali e ambientali e delle attività turistiche
eco-compatibili. È indispensabile che l’istituzione di parchi, riserve,
aree protette avvenga secondo un piano integrato che assicuri la continuità
e la diversità biologica. Vanno promossi piani d’azione per
reintrodurre e conservare specie in via di estinzione, bisogna dedicare
molte energie alle iniziative’di sensibilizzazione della gente,
all’educazione ambientale nelle scuole, all’informazione che veicoli
conoscenza e amore per la natura. È proprio in quest’ottica che abbiamo
lavorato a questa pubblicazione che tratta essenzialmente gli uccelli
rapaci della Calabria, con particolare riferimento alla provincia di
Cosenza. Un rilievo 1specifico è riservato al C.R.A.S. (Centro
di Recupero Animali Selvatici) di Cosenza, che ormai da un decennio svolge
il compito primario di provvedere al recupero e alla riabilitazione dei
tanti selvatici feriti, con l’obiettivo di riportarli, liberi, nel loro
ambiente naturale.
|

